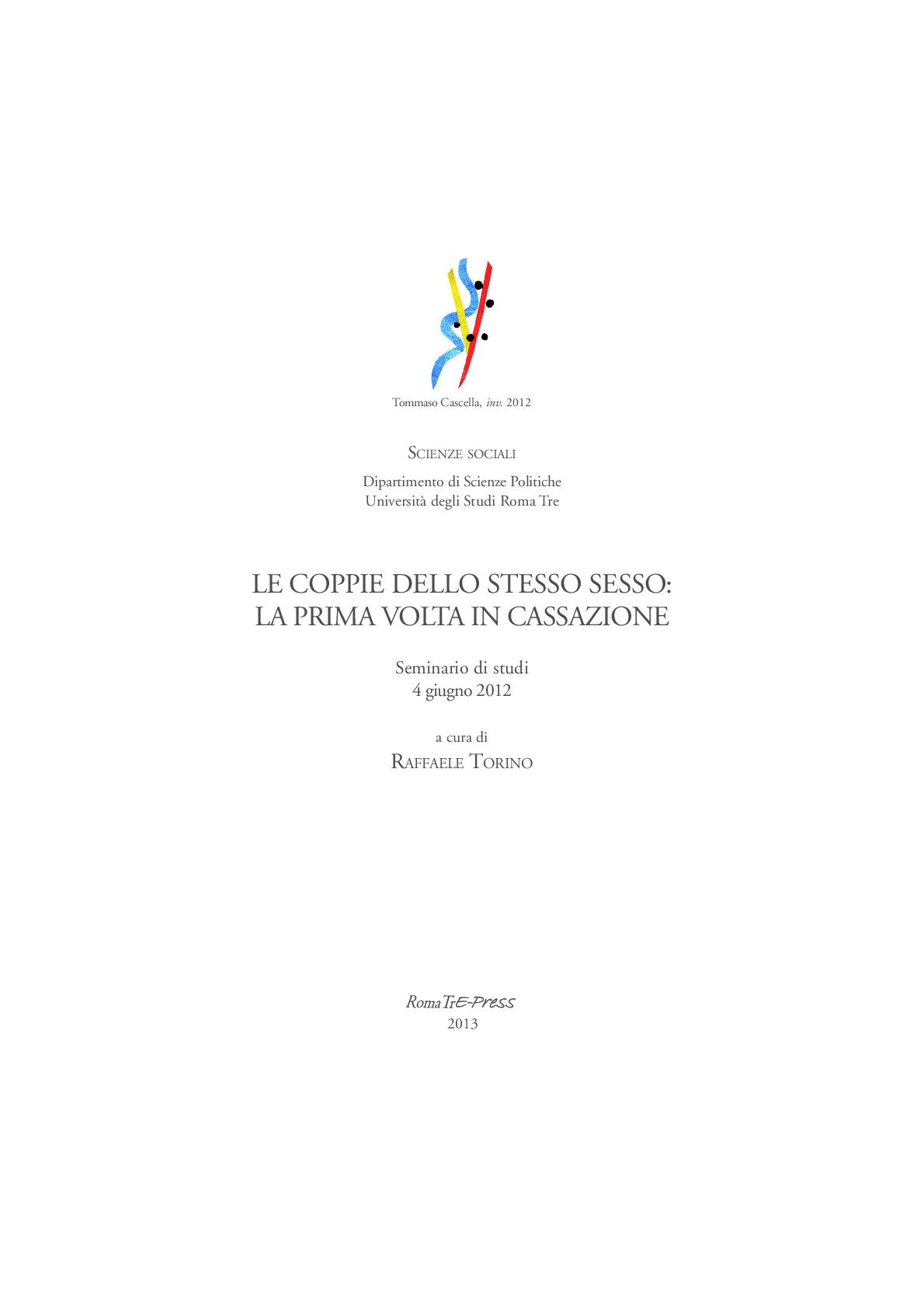
15
OttCapitolo dell’EBOOK “Le coppie dello stesso sesso, la prima volta in Cassazione” edito dall’Università RomaTre dal titolo “La sentenza n. 138-10 della Corte costituzionale, il diritto fondamentale per gli omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppa”
2012-10-15
Capitolo dell’EBOOK “Le coppie dello stesso sesso, la prima volta in Cassazione” edito dall’Università RomaTre dal titolo “La sentenza n. 138-10 della Corte costituzionale, il diritto fondamentale per gli omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppia”
Premessa: il lungo cammino per giungere alla decisione della corte
Prima di affrontare l’esame della sentenza n. 138/10 della Corte Costituzionale è necessario richiamare brevemente i termini dell’iniziativa di affermazione civile realizzata, tra gli altri, dall’associazione Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford, che aveva lo scopo di far nascere un dibattito dottrinario e giurisprudenziale sulla questione del diritto al matrimonio per le persone dello stesso sesso.
In numerosi comuni italiani, sparsi su tutto il territorio nazionale, alcune coppie omosessuali hanno depositato formale richiesta di pubblicazione di matrimonio, al fine di iniziare il procedimento amministrativo portante alla celebrazione dello stesso, ottenendo dagli Ufficiali di stato civile un netto rifiuto, così come previsto dalle circolari ministeriali vigenti in materia [1].
I provvedimenti di diniego emessi sono quindi stati impugnati avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente per materia, in più di venti Fori. Ove i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso è stato proposto appello.
I ricorsi puntavano ad ottenere la disapplicazione degli articoli del codice civile relativi al matrimonio nn. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non prevedono la possibilità di matrimonio same sex, per palese contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 117 Cost., ovvero, in subordine, la remissione degli atti alla Consulta perché ne dichiarasse l’incostituzionalità.
Quattro sono state le ordinanze delle corti di merito che, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale: quelle rispettivamente emesse dal Tribunale di Venezia (RGV 2497/08 depositata il 03.04.09), dalla Corte d’Appello di Trento (RGV 149/09 depositata il 29.07.09), dalla Corte d’Appello di Firenze (RGV 349/09 depositata il 13.11.09) e dal Tribunale di Ferrara (RGV 1163/09 depositata il 11.12.09).
I giudici remittenti, infatti, non hanno ritenuto possibile una disapplicazione tout court del principio di diritto sotteso alle norme codicistiche in questione in quanto, a loro avviso, “l’istituto del matrimonio, così com’é previsto nell’attuale ordinamento, si riferisce indiscutibilmente solo ad una unione fra persone di sesso diverso” (Tribunale Venezia 03.04.09), con la conseguenza che per poter dare una diversa interpretazione alle norme de quibus sarebbe ineludibile il conforme intervento della Corte Costituzionale (di diverso avviso Francesco Bilotta, secondo cui “una nozione di ‘matrimonio’ non si trova né nella Costituzione, né nel Codice Civile; soprattutto, nessuna norma giuridica, esplicitamente, prevede la diversità dei sessi come requisito di validità o esistenza dell’atto matrimoniale” in Le unioni tra persone dello stesso sesso, Mimesis, 2008, sez. IV).
Le motivazioni delle corti remittenti: l’art. 2 cost. e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo
Accertata quindi la necessità di un intervento da parte del Giudice delle Leggi, il primo articolo della Carta Costituzionale che le ordinanze di remissione ritengono in contrasto con il divieto di matrimonio per le persone dello stesso sesso è l’art. 2, nella parte in cui prevede che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Si tratta di una norma che è stata frutto di una grande elaborazione giurisprudenziale e che ha costituito la fonte del riconoscimento di tutta una serie di diritti fondamentali [2] che non risultavano fatti oggetto di un esplicito dettato normativo, quali il diritto alla dignità della persona e quello identità personale.
Il percorso logico operato dalle corti di merito parte dal riconoscimento del diritto della persona alla libera espressione del proprio orientamento sessuale omosessuale.
Il Tribunale di Venezia ricorda come fin dal 1973 negli Stati uniti d’America l’omosessualità è stata cancellata dall’elenco dei disturbi psichici contenuto nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ed è stata trasformata, in ambito psichiatrico, da patologia in caratteristica della personalità, con conseguente introduzione di una nuova definizione della stessa, quale “variante non patologica del comportamento sessuale”.
Successivamente, giova evidenziarlo, in data 17.05.90 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, con efficacia erga omnes in considerazione del suo indiscusso riconoscimento internazionale, ha depennato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali e dal 1993 ha iniziato a definirla “una variante naturale del comportamento umano”.
Di questa mutazione dell’orientamento sociale e scientifico hanno tenuto conto le corti italiane: già nel 1994 la Corte Costituzionale con sentenza 13/1994 ha sancito che “il diritto alla identità personale é il diritto ad essere sé stessi e a quella sfaccettatura di esso costituita dal diritto alla tutela del proprio orientamento sessuale”, con conseguente indiscusso riconoscimento della protezione costituzionale del diritto a manifestare liberamente il proprio orientamento sessuale.
Sulla stessa scia, recentemente, vi sono la sentenza 25.07.07 n. 16417 della I° sezione civile della Cassazione[3] che afferma la “pari identità sociale e giuridica della persona a prescindere dal suo orientamento sessuale” e l’inedita sentenza 12.03.09 n. 16968 della Cassazione penale che, ribaltando la propria precedente giurisprudenza[4], in riforma di una decisione della Corte d’Appello di Bologna ha sostenuto che i sentimenti di affetto e di amore (propri di ogni essere umano) hanno lo stesso valore, sia che si tratti di persona omosessuale che eterosessuale [5].
Accertato come all’orientamento omosessuale già da anni venga riconosciuta pari dignità rispetto a quello eterosessuale sia in ambito scientifico che giurisprudenziale, è opportuno notare come tale impostazione trovi oggi una solida base normativa non solo, in via interpretativa, negli artt. 2 e 3 della Costituzione, ma anche expressis verbis nell’art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) che letteralmente vieta ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
Orbene, secondo la Corte Costituzionale, “la sessualità è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrata tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 impone di garantire” (Corte Cost. 18.12.87, n. 561).
Ciò necessariamente comporta, secondo il Tribunale di Venezia, che l’art. 2 Cost. renda ineludibile la possibilità (rectius riconosca il diritto assoluto, fondamentale e inviolabile), per la persona omosessuale di manifestare ed esprimere liberamente la propria sessualità “non solo nella sua sfera individuale ma anche, e forse soprattutto, nella sua sfera sociale, ossia, secondo la formula della norma, “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, fra le quali indiscutibilmente la famiglia deve essere considerata la prima e fondamentale espressione”. Secondo la famosa sentenza n. 183/1988 della Consulta, infatti, “alla famiglia va il riconoscimento pleno jure di formazione sociale primaria”.
Da questo indiscusso assioma il Tribunale di Venezia trae il corollario che tale libertà di espressione nell’ambito familiare non possa non comprendere anche il diritto inviolabile a sposarsi (o a non sposarsi) con la persona amata, diritto riconosciuto come fondamentale sia normativamente in ambito internazionale, sia in via giudiziale dall’uniforme orientamento della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che, recentemente, con la sentenza 05.05.09, n. 8941, ha ritenuto corretto annullare le disposizioni testamentarie condizionanti l’eredità o il legato alla circostanza dell’avvenuto matrimonio del beneficiario, non solo, come avveniva passato, al mero sposalizio con una persona determinata, trattandosi di una libertà (così) fondamentale, da non poter essere condizionata per motivi patrimoniali.
Alle stesse conclusioni giungono le altre Corti remittenti [6], che pongono anche l’accento su un’ulteriore elemento a sostegno della incostituzionalità delle norme impugnate per contrarietà all’art. 2 Cost.: “il diritto di contrarre matrimonio”, a parere della Corte d’Appello di Trento “costituisce oggettivamente un momento essenziale di espressione della dignità umana”, anch’esso diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, “sicché”, aggiunge la Corte d’Appello di Firenze, “ogni interpretazione riduttiva della tutela accennata sembra del tutto insostenibile” [7].
Un particolare ulteriore aspetto viene poi colto dal Tribunale di Venezia che sottolinea come lo status di persona coniugata assurge a segno caratteristico all’interno della società e conferisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non sostituibili tramite l’esercizio dell’autonomia negoziale. Il riconoscimento pubblico e formale dell’unione nell’atto di matrimonio (o in altro atto di analoga natura), pertanto, costituisce momento essenziale dell’attribuzione di pari dignità al rapporto di amore e solidarietà su cui si fonda e non può essere negato a un consistente gruppo di individui quali i cittadini omosessuali.
Le motivazioni delle Corti remittenti: l’art. 3 cost. e il principio di uguaglianza
Un’altra norma che le Corti remittenti considerano leso dalle norme del Codice Civile è l’art. 3 della Costituzione, secondo il quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Il nostro art. 3, diversamente da alcune recenti carte costituzionali come quella sudafricana, non prevede espressamente il principio di non discriminazione in relazione all’orientamento sessuale, ma la sua interpretazione sistematica, anche alla luce dell’art. 21 della Carta di Nizza, non può esimere il lettore dal ritenerne estesa l’applicazione anche a questo aspetto della natura umana, con conseguente impegno per la Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.
Ovviamente, così come ampiamente elaborato dalle corti di Common Law, l’uguaglianza non può essere solo formale, ma necessariamente deve estendersi al piano sostanziale. Pertanto nulla rileva che la persona omosessuale possa formalmente sposarsi con un’altra persona di sesso diverso, ciò che conta è che ne venga rispettata la dignità sociale e che le venga data la possibilità di unirsi in matrimonio con la persona che ama, impedendo così che la contingente inclinazione sessuale possa costituire motivo di discriminazione fra i cittadini.
Argomenta infatti la Corte d’Appello di Firenze che “bisogna ritenere che la libertà di scegliere un coniuge dotato di un certo sesso piuttosto che di un altro sia garantita dall’ordinamento”.
Invero, secondo il Tribunale di Ferrara, “il diritto di contrarre il matrimonio è un momento essenziale di espressione della dignità umana, esso deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti da sesso o dalle condizioni personali, quale l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo dello Stato ad intervenire in caso di impedimenti dell’esercizio. La norma che esclude o comunque non consenta alle persone omosessuali il diritto di contrarre il matrimonio con persone dello stesso sesso, così seguendo il proprio orientamento sessuale, che non è né patologico e né illegale, non ha alcuna giustificazione razionale, soprattutto se va affrontata l’analoga situazione delle persone transessuali”.
A parere delle Corti remittenti le cosiddette ‘teorie tradizionalistiche’, in base alle quali “il matrimonio è sempre stato fra eterosessuali, e così dovrà sempre essere”, invocano ragioni etiche, legate alla tradizione e alla natura che non costituiscono argomenti idonei a soddisfare il rigore argomentativo richiesto dal giudizio di legittimità. Inoltre è un dato oggettivo che i costumi familiari si sono radicalmente trasformati negli anni, la società italiana, così come quella europea, è cambiata, ci sono tantissime coppie formate da persone omosessuali che convivono, addirittura con figli.
Secondo la Corte d’Appello di Firenze “al giorno d’oggi,(…), sarebbe davvero ridicolo, se non retrivo, contrapporre l’inclinazione omosessuale alla dignità dell’uomo o all’integrità morale del consorzio civile” [8]. Viene in proposito alla mente la sentenza Branse vs Bureau of Vital Statistics del 27.02.98 della Corte Suprema dell’Alaska secondo cui “la questione rilevante non è se il matrimonio tra persone dello stesso sesso sia tanto radicato nelle nostre tradizioni da essere un diritto fondamentale, ma se la libertà di scegliere il proprio “life partner” sia tanto radicata nelle nostre tradizioni”.
Senza appello, in proposito, la sentenza 01.12.2005 della Corte Suprema del Sudafrica che, dichiarando incostituzionale il divieto di matrimonio omosessuale ha dedotto che “l’antichità di un pregiudizio non è una buona ragione per la sua sopravvivenza”, notando che “quando le condizioni umane mutano e le idee di giustizia e di equità si evolvono, anche le concezioni dei diritti assumono nuova trama e significato”.
Il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Ferrara hanno poi sollevato un ulteriore elemento di diseguaglianza: la disparità di trattamento tra le persone omosessuali e quelle transessuali a cui, una volta intervenuta la rettificazione di sesso è concesso dalla legge di sposarsi con una persona avente il proprio sesso di origine.
Tale deduzione discende proprio dall’esame della sentenza n. 161 del 06.05.85 della Corte Costituzionale, che valutando la legittimità costituzionale della legge 164/82, ha riconosciuto il diritto al matrimonio derivandolo dalla necessità di rispettare l’orientamento psico-sessuale dell’individuo transessuale, non dal mero fatto fisico dell’intervenuto mutamento degli organi genitali.
Le motivazioni delle Corti remittenti: l’art. 29 cost. e la famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio
L’articolo 29 Cost. recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Da tale dettato normativo le corti de quibus traggono un ulteriore elemento a sostegno della non manifesta incostituzionalità degli articoli del codice civile impugnati.
A loro avviso, infatti, va seguito il così detto orientamento storicista, secondo cui “la dimensione naturale della famiglia — ciò che fa di essa appunto una “società naturale” — risiede nel fatto che la sua costituzione risponde a un’esigenza connaturata all’essere umano, un bisogno primario e insopprimibile, vincolato all’espressione della sua spontanea socialità, che lo Stato è tenuto a proteggere. Sicché la famiglia, così intesa, si presenta come una realtà aperta alle dinamiche sociali; non già unica e assoluta, bensì plurale e relativa, venendo ad assumere la forma dei modelli che si realizzano in un dato momento storico” [9].
La validità di tale interpretazione è data dal fatto che dal 1948 in poi i mutamenti sociali hanno traghettato la legislazione italiana sulla famiglia da un modello per quell’epoca “tradizionale”, basato su un matrimonio indissolubile e su una struttura gerarchica a subordinazione femminile (che oggi riteniamo universalmente barbara), al modello attuale, che consente il divorzio e che vede l’assoluta parità tra i coniugi.
Il concetto di famiglia, come società naturale, va quindi adeguato al mutamento della realtà fattuale e sociale; deve pertanto, di conseguenza, riconoscere l’esistenza nella nostra società italiana ed europea di numerose famiglie basate su un rapporto omosessuale, prendendo atto della riconosciuta “normalità” (rectius non anormalità) sociale del fenomeno.
Da questo discende, come necessario corollario, che anche la famiglia same sex è una famiglia e deve potersi fondare sul matrimonio ex art. 29 Cost.
Nessun rilievo, infatti, può avere la c.d. funzione procreativa della famiglia in quanto, come affermato dalla Corte d’Appello di Firenze, non c’è dubbio che la finalità procreativa svolga ormai un ruolo soltanto tendenziale nel giustificare l’instaurazione del matrimonio, istituto sicuramente accessibile alle coppie eterosessuali sterili (sempre più numerose per scelta o per necessità), nel perseguimento di interessi solidaristici e morali che sarebbe palesemente incongruo precludere alle coppie omosessuali [10].
Parimenti, come limpidamente argomentato dal Tribunale di Ferrara, va da sé che non può essere attribuito al termine naturale ciò che viene ritenuto tale da una particolare concezione ideologica, religiosa o altro: l’uso di un tale criterio interpretativo sarebbe aberrante in uno Stato che si è fondato costituzionalmente in contrapposizione (e superamento) del modello di Stato etico, quale che sia questa etica.
La Costituzione italiana del dopo-guerra non è certamente eticamente orientata, sebbene si fondi, ovviamente, su dei valori o non potrebbe esistere altrimenti e, date le esperienze del passato, il valore principale fondante è indubbiamente il rispetto della dignità della persona, di ciascuna persona, sia presa in sé come valore assoluto, sia presa in rapporto agli altri, con i quali essa convive e si confronta.
Di conseguenza non appare conforme alla dignità della persona privare qualcuno della possibilità di fondare una famiglia in ragione di un criterio come quello dell’orientamento sessuale, che, come quello della razza, della nazionalità, dell’origine etnica, ecc., non fa parte delle scelte individuali, ma è dato, inerente, connaturato, congenito.
Le motivazioni delle Corti remittenti: l’art. 117 cost. e il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
Da ultimo, le Corti che hanno sollevato la questione di incostituzionalità, traggono ulteriore sostegno alla propria tesi dall’interpretazione sistematica dell’art. 117 della Costituzione.
A loro parere, il necessario adeguamento a fonti del diritto quali la Carta di Nizza e la convenzione C.E.D.U., che garantiscono il diritto alla vita familiare e alla non discriminazione basata sull’orientamento sessuale, così come il diritto a sposarsi, non può che passare attraverso il riconoscimento del diritto al matrimonio anche per le coppie omosessuali.
Tale convinzione nasce anche dall’esame della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha accolto una nozione di “vita privata” e di tutela dell’identità personale in essa insita, non limitata alla sfera individuale, bensì estesa alla vita di relazione, arrivando a configurare un dovere di positivo intervento degli Stati di rimediare alle lacune suscettibili di impedire la piena realizzazione personale.
Viene a tal proposito fatto espresso riferimento al caso Goodwin vs Regno Unito, 17/7/2002, quando la Corte di Strasburgo ha dichiarato contrario alla Convenzione il divieto di matrimonio del transessuale con persona del suo stesso sesso originario, per violazione del principio di rispetto della vita privata, superando il proprio precedente orientamento con il quale aveva ritenuto che il diritto di sposarsi garantito dall’art. 12 CEDU potesse essere riferito solo a persone di sesso biologico opposto (Rees vs Regno Unito, 17/10/1986), riconoscendo di fatto che non ha senso essere titolari di un diritto al matrimonio, se poi non si può scegliere con chi sposarsi [11].
La decisione della Corte Costituzionale: il diritto per gli omosessuali alla vita familiare
La pronuncia della Corte Costituzionale si compone di un doppio dispositivo, equamente distribuito per le quattro norme parametro costituzionali che i giudici a quibus hanno indicato quali norme rilevanti per la valutazione circa la legittimità costituzionale; le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 Cost. e 117, comma 1, Cost. sono dichiarate inammissibili, quelle afferenti gli artt. 29 Cost. e 3, comma 1, Cost. sono dichiarate non fondate.
Pur essendo stata rigettata la questione di legittimità, questa sentenza rappresenta comunque una svolta storica nella giurisprudenza italiana, in quanto porta ad un vero e proprio ribaltamento di prospettiva: non si discute più se la Costituzione vieti o meno il riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, ma se e in che termini imponga il riconoscimento normativo di tali diritti [12].
Viene definitivamente riconosciuta una rilevanza costituzionale alle unioni omosessuali e, di conseguenza, ritenuta necessaria una disciplina legislativa di carattere generale che ne disciplini diritti e doveri. In altri termini, la famiglia omosessuale entra finalmente, e prepotentemente, nell’ambito dell’universo giuridico del nostro ordinamento e vi fa il proprio ingresso dalla porta principale, sotto la stella protettrice della Costituzione Italiana.
Passando all’esame del testo della sentenza 128/10, la novità più rilevante è relativa alla interpretazione data dalla Consulta all’art. 2 Cost..
La Corte rileva un contrasto tra gli articoli del codice civile, sistematicamente interpretati, e i principi costituzionali, tuttavia, il superamento del conflitto non le appare costituzionalmente obbligato, non essendovi un’unica via praticabile per eliminare il vizio di incostituzionalità (coerente con la logica del sistema giuridico italiano) [13].
Essa infatti ritiene che la questione, così com’è stata posta, necessita di una interpretazione additiva e pertanto, a suo avviso, è dunque imprescindibile che il Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, all’interno della rosa delle scelte normative possibili, tra cui indubbiamente rientra anche l’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, individui delle forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni same sex.
Tale intervento dovrà comportare obbligatoriamente “una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia” che dovrà tener conto del diritto fondamentale (e di conseguenza inalienabile) di cui sono titolari anche le persone omosessuali, di vivere liberamente una condizione di coppia, così come desumibile interpretativamente dall’art. 2 Cost.
Il carattere innovativo della sentenza risiede proprio nel riconoscimento come diritto fondamentale del libero sviluppo della persona anche nell’ambito della coppia omosessuale. La Corte, infatti, avanza una lettura dell’art. 2 Cost., in relazione alle unioni omosessuali, assai significativa e per nulla pacifica — né sul piano dottrinario e ancor meno sul piano giurisprudenziale — che, a ragione, autorevoli commentatori hanno giudicato sia destinata ad assumere nell’ordinamento italiano una portata storica [14] .
La Consulta, infatti, con questa sentenza, è passata dal riconoscimento del diritto di vivere liberamente la propria condizione di persona omosessuale, a quello di vivere liberamente una condizione di coppia omosessuale: ora è anche la coppia nel suo insieme ad essere tutelata dalla Costituzione; essa è infatti considerata a pieno titolo una formazione sociale in cui l’individuo ha il diritto di realizzare sé stesso [15], in sostanza viene equiparata, a tutti gli effetti, ad una famiglia.
Sul punto di grande incisività è Marco Gattuso [16], secondo cui “con l’affermazione, da parte della Corte Costituzionale – nella sentenza n.138 del 2010 – della rilevanza costituzionale dell’unione omosessuale, d’un fenomeno, dunque, che assume necessariamente rilevanza esterna, si dà atto della necessità costituzionale di assicurare tutela anche per le manifestazioni esteriori della affettività”. Qui non si parla del diritto delle persone consenzienti di fare sesso nel chiuso delle loro camere da letto; si tratta del diritto di amarsi, di passeggiare tenendosi per mano, di baciarsi in pubblico, di vedere trattato in un film l’amore omosessuale al pari di quello eterosessuale.
Non è però soltanto un riconoscimento di natura culturale. E’ un riconoscimento giuridico vero e proprio che comporta non solo una totale equiparazione tra le coppie conviventi more uxorio, eterosessuali ed omosessuali, ma anche la necessità per il legislatore di garantire, “in relazione ad ipotesi particolari”, “un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza”
La Consulta, infatti, si è espressamente riservata, con questa sentenza, “la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988)” e questo, chiaramente, sia in relazione alla disciplina legislativa che il Parlamento vorrà adottare, sia in relazione alle norme attualmente vigenti, disciplinanti particolari aspetti della vita sociale, nelle more dell’introduzione della necessaria disciplina di carattere generale.
Così come lucidamente afferma Barbara Pezzini, la discrezionalità del legislatore viene riconosciuta in funzione di limite rispetto alla possibilità di una pronuncia manipolativa di tipo additivo da parte della Corte, ma risulta anche precisamente indirizzata e delimitata, tant’è vero che risultano specificamente prefigurati persino i rimedi attivabili in caso di un esercizio carente o inadeguato della discrezionalità legislativa stessa. Il riferimento alla piena discrezionalità del legislatore va, quindi, letto alla luce della nuova interpretazione data all’art. 2 Cost. [17].
La Consulta, come sostiene correttamente Gattuso, ha quindi quasi individuato uno spazio intermedio tra le convivenze eterosessuali more uxorio (che attualmente possono liberamente essere trasformate in matrimonio) e le coppie coniugate, inserendovi le convivenze omosessuali, che per la attuale situazione normativa in essere non possono evolversi in un rapporto di coniugio [18].
Sicché questo apre la via, non solo a possibili giudizi dinnanzi alla Corte Costituzionale tesi a verificare la ragionevolezza della disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali sposate e quelle omosessuali conviventi, ma anche, e soprattutto, ad un vero e proprio controllo di legittimità costituzionale “dal basso”, diffuso sul territorio, in quanto è compito precipuo del giudice disapplicare tout court la legge ordinaria, ovvero darle una interpretazione costituzionalmente orientata, ogni qualvolta questa risulti in contrasto con l’art. 2 Cost. così come inteso dalla sentenza in esame della Corte Costituzionale [19].
Ciò posto, sicuramente nessuna ragion d’essere può più avere una disparità di trattamento fra coppie conviventi more uxorio eterosessuali ed omosessuali. E’ quindi da considerare più che valido e condivisibile l’orientamento giurisprudenziale già manifestato da alcune corti di merito[20] che ha visto attestata la rilevanza della relazione di convivenza ai fini della sublocazione di un immobile [21], riconosciuto la qualifica di obbligazione naturale alle donazioni tra conviventi omosessuali [22], accertato il diritto del convivente omosessuale more uxorio ad iscriversi alla Cassa Mutua nazionale per le banche di credito cooperativo [23], riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte del convivente omosessuale [24] o il diritto a costituirsi parte civile nel processo penale a carico del presunto assassino [25].
Già i primi risultati della sentenza n. 138/10 sul questo punto si sono visti in concreto.
A puro titolo esemplificativo si può citare l’orientamento espresso dal Tribunale di Reggio Emilia che ha riconosciuto il diritto al coniuge extracomunitario same sex di cittadino italiano di ottenere, sulla base del matrimonio contratto all’estero, il permesso di soggiorno [26], che ha portato ad un adeguamento spontaneo anche da parte delle questure non interessate da quel procedimento, oggi esteso anche agli individui che hanno stipulato unioni civili (e non solo matrimoni) all’estero con cittadini italiani (con ciò disattendendo l’orientamento espresso recentemente in materia dalla Corte di Cassazione con sentenza Sez. I, 17.03.2009, n. 6441 [27]).
Sintomo del nuovo clima è pure la modifica operata in via di autotutela dal Ministero dell’Interno ad una propria circolare in materia di mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, che ha eliminato il riferimento al sesso diverso dei conviventi more uxorio in relazione all’equiparazione di quel tipo di rapporto a quello di coniugio in funzione dell’attribuzione dei punteggi per i trasferimenti [28].
La decisione della Corte Costituzionale: il mancato obbligo di riconoscere il diritto al matrimonio
Una volta riconosciuto il diritto delle coppie omosessuali alla vita familiare sulla base dell’art. 2 Cost., la Consulta non ritiene che dall’art. 29 Cost. discenda un loro diritto al matrimonio.
Infatti, dopo aver iniziato il proprio ragionamento apparentemente richiamando l’orientamento storicista, vira verso una interpretazione definita dal Mastromartino come storico-originalista [29].
Secondo la Corte, infatti, “è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata”.
Di conseguenza, “questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa”.
Questa lettura data dalla Consulta all’art. 29 Cost. è, a parere di chi scrive, intrinsecamente errata.
A prescindere dal fatto che l’argomento originalista è stato impiegato dalla Corte soprattutto nei primi anni della sua attività e che dal 2000 in poi non è più stato utilizzato nel quadro di decisioni in materia di diritti, nella precedente giurisprudenza costituzionale non possiede mai una funzione decisiva. Nell’ambito di una argomentazione assolve invece generalmente un ruolo suppletivo ed integrativo, essendo il suo impiego volto fondamentalmente a suffragare interpretazioni che si ricavano altrimenti, attraverso l’uso di altri argomenti.
Inoltre, l’orientamento espresso sul punto dalla Consulta contrasta platealmente con l’interpretazione evolutiva data nella medesima sentenza in relazione all’art. 2 Cost. ed al riconoscimento del diritto per le coppie omosessuali alla vita familiare, che presuppone il recepimento di un concetto di famiglia preso non certo in considerazione dai padri costituenti [30].
Peraltro, collegando il concetto di matrimonio al concetto tradizionale dello stesso, “finisce per schiacciare la famiglia sul mero dato giuridico-positivo, peraltro di formazione precedente alla Carta, essendo la disciplina del matrimonio contenuta nel codice civile del 1942. Sicché si realizza un ribaltamento della gerarchia delle fonti, in forza del quale la disposizione costituzionale, nella parte in cui si riferisce alla famiglia, viene interpretata in base a una fonte di ordine inferiore, rispetto alla quale, al contrario, dovrebbe possedere una vincolante normatività” [31].
Inoltre, si pone in contrasto con la stessa “ratio legis” espressa dai padri costituenti in relazione all’art. 29 Cost., come chiaramente evincibile da alcune considerazioni svolte, in Assemblea Costituente dall’on. Aldo Moro nella seduta del 30.10.1946: “La famiglia è la cerchia sociale nella quale l’uomo si esprime più naturalmente; va considerata, in quanto tale, come un limite dello Stato […] come garanzia della stessa democrazia; lo Stato ha dinanzi a sé delle realtà autonome da cui esso stesso prende le mosse, sia pure, a sua volta, influenzandole” [32].
La decisione della Corte Costituzionale: l’assenza di discriminazione derivante dall’orientamento sessuale
Quanto poi alla eccepita illegittimità costituzionale delle norme codicistiche impugnate, per contrasto col principio di uguaglianza contenuto all’art. 3 Cost., la Corte nega l’esistenza di una irragionevole disparità di trattamento su un doppio ordine di considerazioni.
In primo luogo, di fronte al combinato disposto degli artt. 3 e 29 Cost., la Consulta invece di utilizzare la pretesa soggettiva all’uguaglianza quale corretta premessa del ragionamento, riducendone ab initio la complessità ed evitando la manipolazione normativa della realtà, sceglie di assumere come riferimento principale l’istituto del matrimonio così come sopra interpretato, rovesciando così i termini di paragone e degradando l’uguaglianza da situazione soggettiva assoluta, sulla base della quale verificare eventuali discriminazioni, a mera ragionevolezza nella valutazione delle disparità di trattamento[33], ragionevolezza che, peraltro, non si preoccupa neppure di declinare e argomentare [34]. In questo modo risulta “alla fine ragionevole il criterio distintivo basato sul paradigma eterosessuale in quanto il legislatore avrebbe, a suo tempo, accolto tale paradigma nella disciplina legislativa” [35].
In secondo luogo ritiene che “la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”.
Tale affermazione non risulta solo apodittica, non trovando nel prosieguo della motivazione nessuna dimostrazione, ma appare intrinsecamente errata in quanto, come ricorda Gattuso, la Corte sembra comparare una realtà sociale qual’è l’unione omosessuale con un istituto giuridico come il matrimonio così compiendo un inspiegabile errore di ordine categoriale [36].
La decisione della Corte Costituzionale: la mancata violazione della normativa europea
Da ultimo, la Corte ritiene inammissibile la questione di incostituzionalità anche in relazione all’art. 117 Cost. sulla base della considerazione che la normativa europea non impone il modello matrimoniale quale unica modalità di regolamentazione giuridica dell’unione omosessuale.
Vari sono, infatti, gli istituti utilizzabili, tutti ugualmente validi a garantire quella necessaria normativa di carattere generale che la Corte ritiene necessaria per la tutela e la regolamentazione delle coppie omosessuali: dal matrimonio vero e proprio (come in Spagna o in Belgio), alle unioni civili che, salvo il nomen juris, conferiscono ai partecipanti gli stessi diritti e doveri del coniugio (come in Gran Bretagna), alle unioni civili che prevedano diritti ridotti (come in Germania o in Austria) ai P.A.C.S. (come in Francia).
Peraltro, secondo la Consulta il richiamo alla sentenza Goodwin vs Regno Unito dell’11.07.02 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo viene considerato non pertinente perché, come già argomentato in sentenza in relazione all’art. 3 Cost., a parere della nostra Corte Costituzionale è incomparabile la condizione dell’omosessuale con quella del transessuale che ha ottenuto la rettificazione di sesso, in quanto “nel transessuale (…) l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile, di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza (sentenza n. 161 del 1985, punto tre del Considerato in diritto). La persona è ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente ordinamento”.
In nessun conto la Corte tiene le motivazioni che l’hanno portata, nella sentenza n. 161/85, a ritenere costituzionalmente legittimo il matrimonio del transessuale, che avevano come stella polare il rispetto dell’ “orientamento psico-sessuale” del transessuale [37].
Conclusioni
Sicuramente, come si è visto, il riconoscimento del diritto fondamentale per gli omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppia costituisce la grande novità della sentenza n. 138/10, anche e soprattutto per le conseguenze che l’interpretazione dell’art. 2 Cost. ha già avuto e potrà avere a cascata in futuro sulla giurisprudenza e sulla stessa legislazione, quale la sentenza n. 4184/12 della Corte di Cassazione che, elaborando l’insegnamento della Consulta, ha espressamente affermato il diritto per le coppie omosessuali di essere considerate una famiglia.
D’altra parte questo provvedimento non ha sciolto il dubbio sulla costituzionalità del matrimonio tra persone dello stesso sesso e ciò correttamente, perché non questo era chiamata a risolvere. Il quesito infatti poneva la questione se il divieto di contrarre il matrimonio per le coppie omosessuali contenuto nelle attuali norme codicistiche fosse incostituzionale, cioè se, nell’attuale sistema costituzionale e normativo, le persone omosessuali avessero il diritto, costituzionalmente garantito a sposarsi. Non veniva chiesto se la Costituzione italiana vietasse o meno il matrimonio same sex.
Ciò nonostante la dottrina ha animosamente e lungamente dibattuto se, nelle pieghe della sentenza in esame, potesse individuarsi un orientamento sul punto.
Alcuni ritengono che l’aver affermato che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio abbia voluto alludere al fatto che, al di là del dato giuridico legislativo e costituzionale, vi sarebbe una tradizione sedimentata da tempo immemorabile, che letteralmente precluderebbe al legislatore di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali, in forza del fatto che l’iniziativa del Parlamento non potrebbe che risultare impotente di fronte alla resistenza di ciò che deve rimanere così poiché così è sempre stato [38], con la conseguenza che “nel nostro ordinamento, la diversità di sesso resta un elemento necessario ed imprescindibile per l’esistenza stessa del matrimonio, così come già era stato concepito dai costituenti nella formulazione dell’art. 29 Cost.”[39], altri addirittura dissentono dalla stessa interpretazione data dalla Corte all’art. 2 Cost., negando ogni la tutela alle coppie same sex perché ex art. 29 Cost. non potrebbero essere considerate famiglia [40], alcuni arrivano persino a motivare il proprio orientamento sulla base della “verità rivelata” espressa dalla nota del Consiglio episcopale permanente del 28.03.07, secondo cui “le situazioni giuridiche dei conviventi di fatto anche omosessuali dovrebbero trovare soddisfazione esclusiva nell’ambito dei diritti individuali, senza la necessità di ravvisare una nuova figura giuridica «alternativa al matrimonio e alla famiglia» e che «produrrebbe più guasti di quelli che vorrebbe sanare»” [41].
Altri, come il Gattuso, ritengono che la Corte semplicemente non si sia espressa sul punto, in quanto in tutta la motivazione la Corte non introduce nessun elemento espressamente diretto a condizionare la discrezionalità del legislatore, né sarebbe conforme alla sua pregressa giurisprudenza in materia familiare coartare, in un senso o nell’altro, la volontà parlamentare. Inoltre dalla lettura della sentenza non emerge alcun argomento per sostenere che l’apertura al matrimonio violi diritti od interessi di terzi e della famiglia eterosessuale e che quindi si contrapponga alla ratio di garanzia dell’art. 29 Cost. [42].
Altri, infine, con argomentazioni tutt’affatto condivisibili, ritengono che la Corte si sia già di fatto espressa per la legittimità costituzionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso [43].
In particolare la Pezzini basa la sua argomentazione sulla stessa motivazione della Consulta relativa all’interpretazione dell’art. 29 Cost, nella parte in cui deriva il significato del concetto di matrimonio, quale “società naturale” dalla visione tradizionale e dalla implicita definizione data all’istituto stesso dal Codice Civile. Orbene “visto che la Corte Costituzionale fa riferimento a quello che è il Codice Civile come base, nel momento in cui cambiasse la normativa di riferimento, è ovvio che il ‘substrato’ che sta sotto l’interpretazione della Corte Costituzionale viene meno. Di conseguenza bisognerebbe adeguare l’interpretazione dell’art. 29 alla situazione di fatto anche del diritto vigente, e di conseguenza vi sarebbe addirittura una copertura costituzionale dell’art. 29 al matrimonio fra le persone dello stesso sesso” [44].
Questa interpretazione trova linfa e sostegno nella sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani “Schalk and Kopf” del 24.06.2010 che, innovando profondamente la propria giurisprudenza, ha dato una nuova nozione di matrimonio, che comprende espressamente anche le coppie formate da coniugi dello stesso sesso.
In conclusione, cristallino e inconfutabile rimane, a parere di chi scrive, il ragionamento con cui la Corte Suprema del Sudafrica, con la sentenza Minister of Home Affairs vs Fourie del 01.12.2005, ha dichiarato incostituzionale il divieto di matrimonio omosessuale, ritenendo che “l’antichità di un pregiudizio non è una buona ragione per la sua sopravvivenza” in quanto “quando le condizioni umane mutano e le idee di giustizia e di equità evolvono, anche le concezioni dei diritti assumono nuova trama e significato”, perché, come affermato dalla Corte Suprema del Massachusetts, con la sentenza Goodridge vs Department of Pubblic Healt del 18.11.2003, “il diritto di contrarre matrimonio significa ben poco, se non include il diritto di sposare la persona che si è scelto di amare.”
[1] Ministero Interno, nota 28.07.2004, prot. 04005452-15100/15952 e Ministero Interno, circolare 18.10.07, n. 55, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone., 2008, 549.
[2] Di notevole intensità e chiarezza, sul punto, è la definizione di diritto fondamentale data dal compianto prof. Galgano: “Ci sono diritti che sono creati dal diritto oggettivo, secondo quel processo di soggettivazione che abbiamo a suo luogo descritto; ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo trovati dal diritto oggettivo: sono i diritti dell’uomo, che si considerano esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca e che questo si limita a garantire. A differenza di ogni altro diritto soggettivo, la cui esistenza dipende dalla mutevole valutazione dello Stato-ordinamento – mutevole nel tempo e nello spazio, a seconda dei diversi sistemi politici e sociali – i diritti dell’uomo, detti anche diritti della persona umana o diritti della personalità, si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale, indipendentemente dal tipo di sistema politico o sociale entro il quale egli vive, e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e di garantire.” (…) “Ad essi la nostra Costituzione fa riferimento nell’art. 2: << la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità >>. Questo loro carattere di inviolabilità ha un duplice referente: sono diritti dell’uomo inviolabili da parte della pubblica autorità, nell’esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono inoltre diritti dell’uomo inviolabili da parte degli altri uomini, nell’ambito dei rapporti fra privati.” Francesco Galgano – Diritto Privato , Terza Edizione, Padova, 1985, pagg. 84-85.
[3] in Diritto dell’immigrazione e della cittadinanza, 2007, 126.
[4] Nel 1968 la Cassazione penale sosteneva ancora che “l’omosessualità rappresenta di per sé una anomalia una alterazione del comportamento sessuale” (Cass. pen., 12.03.68, n. 428 in Archivio Penale, 1970, n. 33) e nel 1979 indicava i rapporti omosessuali come “innaturali” (Cass. pen., 26.04.79, n. 6535, in Foro Italiano 1980, II, 32).
[5] “Non ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all’omicidio commesso da un omosessuale in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto. Deve infatti escludersi che il concetto di “abietto” possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale” (CED Cassazione 2009).
[6] secondo la citata ordinanza del Tribunale di Ferrara “il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello sovranazionale (artt 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, artt 8 e 12 CEDU e ora all’artt. 7 e 9 della Carta di Nizza del 7-12-2000), sia dall’art. 2 della Costituzione: è un diritto inteso sia nella sua accezione positiva di libertà di contrarre matrimonio con la persona prescelta (così anche Coste Cost. n° 445/2002), sia in quella negativa di libertà di non sposarsi e di convivere senza formalizzare l’unione (Corte Cost. 13-5-98 n° 166). La libertà di sposarsi (o di non sposarsi) e di scegliere il coniuge autonomamente riguarda la sfera dell’autonomia e dell’individualità ed è quindi una scelta sulla quale lo Stato non può interferire, a meno che non vi siano interessi prevalenti incompatibili; ora, nell’ipotesi in cui una persona intenda contrarre matrimonio con altra persona dello stesso sesso nessun pericolo di lesione ad interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale, quali potrebbe essere la sicurezza o la salute pubblica, appare verificarsi”.
[7] Corte Appello Firenze (13.11.09) “innanzi tutto, sembra davvero arduo negare al diritto di sposarsi – che non a caso è divenuto uno dei cavalli di battaglia delle militanze omosessuali in tutto il mondo – la dignità di diritto fondamentale della persona. L’art. 2 cost. “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e non v’è il minimo dubbio che l’unione coniugale costituisca un sodalizio in cui si esprima la personalità dell’individuo, anzi può ben dirsi che costituisca il nucleo sociale in cui la personalità dell’individuo trova l’espressione più intima e basilare, sicché, se la carta costituzionale si preoccupa di garantire e tutelare senza discriminazioni l’accesso dell’individuo alle più varie formazioni sociali (di tipo politico, sindacale, culturale o sportivo), davvero non si vede come possa restare indifferente alla preclusione del matrimonio rispetto all’ individuo di orientamento omosessuale. Che l’istituto della coniugio esprima uno dei profili essenziali in cui si manifesta la dignità umana, del resto, è apertamente riconosciuto dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritto dell’Uomo del 1948, nonché dagli artt. 8 e 12 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1952 e, infine, dagli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000, sicché ogni interpretazione riduttiva della prospettiva di tutela accennata sembra del tutto insostenibile.”
[8] “Il progresso della sensibilità comune ha ormai felicemente emancipato l’omosessualità dal ghetto di emarginazione, se non di aperta repressione, in cui ideologie autoritarie del passato l’avevano confinata, facendo comprendere e rispettare alla generalità dei consociati “un modo d’essere” (per usare le parole spese da Corte Cost. n. 165/1985 per i transessuali) che risponde a moti insindacabili dell’animo umano, di cui la normativa di un ordinamento civile non può che prendere atto e consentire l’affermazione, evitando anzi ingerenze e sgombrano il campo da ogni ostacolo al dispiegarsi del diritto di autodeterminazione di ciascuno.” Corte Appello Firenze, 13.11.09.
[9] Francesco Mastromartino, Il matrimonio conteso: le unioni omosessuali in un’eclettica pronuncia della Corte Costituzionale italiana, in Diritto e Famiglia 2011, 01, 439. Vedasi anche Mancini, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art. 29 Cost., in Riv. dir. civ., 1963, 223 e ss.; P. Barcellona, Famiglia (dir. civ.), in Enciclopedia del diritto, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 780 ss., secondo cui per individuare il denotato del concetto di famiglia si deve “far leva esclusivamente sui modi di rilevanza concretamente riscontrabili in un determinato sistema positivo”.
Per una ricostruzione esemplare di questo orientamento, cfr. R. Bin, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium iuris, 10, 2000, 1066-1067
[10] Si veda, in proposito, Andrea Pugiotto Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, relazione svolta al Convegno “Questioni attuali in materia di famiglia”, Verona, Facoltà di Giurisprudenza, 29.02.08.
[11] Va evidenziato come, nel cambiare il proprio orientamento, la Corte abbia fatto riferimento a quello che ha definito come “the very essence of the right to marry” e all’artificiosità dell’idea che i soggetti transessuali dopo l’operazione, non sarebbero privati del diritto di sposarsi potendo comunque sposare una persona del sesso opposto a quello loro originario.
[12] Sul punto leggasi Marco Gattuso, La sentenza della Corte Costituzionale apre nuove prospettive di tutela in Politeia , n. 100, 2010.
[13] A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, terza ed., Giuffrè, Milano, 2001, 236.
[14] F. Dal Canto, La Corte Costituzionale e il matrimonio omosessuale, 1370 e M. Gattuso, , La Corte Costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Famiglia e Diritto, 7, 2010, 657-658.
[15] Sul punto particolarmente efficace è Pezzini, secondo cui “la sentenza specifica che le formazioni sociali di cui parla l’art. 2 vanno intese nel contesto di valorizzazione del modello pluralistico e vengono identificate in ogni forma di comunità, semplice o complessa, in base alla capacità di rendere possibile ed agevolare il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. Su tale premessa definitoria, rileva che l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, va annoverata fra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 Cost. e, di conseguenza, identifica la tutela costituzionale garantita alle unioni omosessuali ricavando direttamente dall’art. 2 il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia same sex” (in Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. N. 138 del 2010 della Corte costituzionale pubblicato su Giurisprudenza Costituzionale 2010, 3, 2715)
[16] in Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza pubblicato su La nuova giurisprudenza civile commentata n. 12 del dicembre 2011.
[17] Barbara Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 3, 2715.
[18] Marco Gattuso, Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza cit.
[19] di estrema chiarezza sul punto il Gattuso secondo cui “poiché, come noto, un giudice può promuovere una questione di legittimità costituzionale soltanto nel caso in cui la questione non possa essere risolta già attraverso un’interpretazione adeguatrice della norma, il giudice, innanzi ad una coppia che chieda tutela e che a suo avviso necessiti d’un trattamento omogeneo a quello di una coppia coniugata, dovrà applicare direttamente la normativa prevista per la coppia sposata, attraverso una interpretazione analogica, evolutiva, costituzionalmente orientata della norma, e solo se tale interpretazione non sia possibile dovrà ricorrere alla Corte Costituzionale perché verifichi se la disparità di trattamento sia legittima” Marco Gattuso, La sentenza della Corte Costituzionale apre nuove prospettive di tutela in Politeia , n. 100, 2010.
[20] di cui dà conto analiticamente Marco Gattuso in Orientamento sessuale, famiglia, eguaglianza cit.
[21] Trib. Roma, 20.11.1982, in Riv. Giur. Edil, 1983, I, 959, per cui “la convivenza more uxorio nell’immobile locato, del conduttore omosessuale con un amico, alla pari dell’ipotesi di convivenza tra eterosessuali, esclude la configurabilità di un rapporto di sublocazione che legittima il locatore a chiedere la risoluzione del contratto”.
[22] Trib. Firenze, 11.08.1986, in Dir.eccl., 1989, II, 367, Trib. Milano, 01.07.1993, in Gius, 1994, 103.
[23] Trib. Milano, Sez. Lavoro, 15.12.09, inedita.
[24] Trib. Milano, ord. 13.11.2009, in Resp. civ. e prev., 2010, 412, con nota di Bilotta, La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora un tabù?
[25] G.U.P. Roma, ord. 19.07.2007, inedita
[26] Trib. Reggio Emilia, RGV 1401/11, 13.02.2012, inedita
[27] secondo cui “In tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un’unione di fatto debitamente attestata nel paese d’origine del richiedente, non può essere qualificato come “familiare” ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett. c) d.lg. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale.” Cass. Civ. Sez. I, 17.03.09, n. 6441 in Giust. civ. Mass. 2009, 3, 464
[28] Ministero Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Circolare 333-A/9807.E.1./3368-2012 del 14.05.2012, modificata dalla Circolare 333-A/9807.E.1./6750-2012 del 17.09.2012 del medesimo organo.
[29] Francesco Mastromartino, Il matrimonio conteso: le unioni omosessuali in un’eclettica pronuncia della Corte Costituzionale italiana, cit.
[30] Dello stesso avviso Francesco Dal Canto, La Corte Costituzionale e il matrimonio omosessuale, in Il Foro Italiano, I, 2010, 1371
[31] Francesco Mastromartino, Il matrimonio conteso, cit.
[32] in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, Tipografia della Camera dei Deputati, VI, Roma, 1971, 635
[33] Barbara Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare, cit.
[34] Francesco Mastromartino, Il matrimonio conteso: le unioni omosessuali in un’eclettica pronuncia della Corte Costituzionale italiana, cit.
[35] Barbara Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare, cit.
[36] M. Gattuso, La Corte Costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso, cit., 658.
[37] Corte Cost. n. 161/1985: “E poiché il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione è spinto e costretto dal suo “naturale” modo di essere, il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire – sempre secondo le indicazioni della medicina – l’intervento chirurgico risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso. In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si è voluta dare carico anche di questi “diversi”, producendo una normativa intesa a consentire l’affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza.”
[38] Per tutti, R. Romboli, Il diritto Consentito al matrimonio e il diritto garantito alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice troppo e troppo poco in Rivista dell’associazione italiana dei costituzionalisti, 02.07.10, su www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2, R. Romboli, Per la Corte Costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali che non possono accedere al matrimonio, in Foro Italiano, I, 2010, 1368, A. Melani, Il matrimonio omosessuale dopo la pronuncia della Corte Costituzionale: la questione resta aperta, Quaderni costituzionali su www.forumcostituzionale.it, 12, F. Dal Canto, La Corte Costituzionale e il matrimonio omosessuale, in Foro Italiano, I, 2010, 1372, P.A. Capotosti, Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versus inammissibilità nella sentenza n. 138 del 2010, in Quaderni Costituzionali, 2, 2010.
[39] Laura Morlotti, Il no della consulta al matrimonio gay , in Resp. Civ. e prev. 2010, 7-8, 1505
[40] Giacobbe, Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto, in Dir. fam., 2009, 307 ritiene che “dovendosi ricostruire il sistema ordinamentale costituzionale nel suo complesso, l’art. 2 cost. deve essere interpretato avuto riguardo a quanto dispone il successivo art. 29 cost. Ciò comporta che nel sistema delineato dalla Costituzione, la tutela generale ed indifferenziata delle formazioni sociali, con riferimento alla famiglia, trova specificazione nell’art. 29: il quale, identificando l’aggregazione familiare, alla quale riconosce diritti, nella società naturale fondata sul matrimonio, ha determinato sul piano normativo di rilevanza costituzionale che non ogni aggregazione interpersonale può essere qualificata come famiglia, ma soltanto quella aggregazione che ha nel matrimonio il suo fondamento, nel senso che l’atto matrimonio costituisce il titolo giuridico per l’attribuzione e quindi l’esercizio dei diritti riconosciuti alla famiglia”.
[41] R. Pinardi, La Corte, il matrimonio omosessuale e il fascino (eterno?) della tradizione, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 11, 2010, pp. 527-536.
[42] Marco Gattuso, La sentenza della Corte Costituzionale apre nuove prospettive di tutela cit., ove tra l’altro si legge “L’ancoraggio proposto dalla Corte all’intenzione soggettiva dei costituenti pare strettamente connesso alla necessità di prevenire interpretazioni “creative”, d’evitare cioè fughe in avanti giurisprudenziali, di salvaguardare il principio di tripartizione dei poteri, come potrebbe già desumersi dall’indicazione per cui «questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica». Alla Corte, peraltro, è stato chiesto se l’art. 29 imponga il riconoscimento del matrimonio tra omosessuali, mentre non è stato chiesto se l’art. 29 possa consentire tale apertura. Sarebbe allora certamente paradossale che al disconoscimento della Corte di interpretazioni “creative” del giudice consegua una limitazione per lo stesso potere legislativo, imposta… proprio per via giudiziaria!”
[43] Barbara Pezzini in Il matrimonio same sex si potrà fare, cit.
[44] Barbara Pezzini in Il matrimonio same sex si potrà fare, cit.